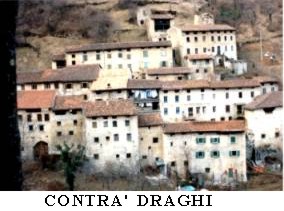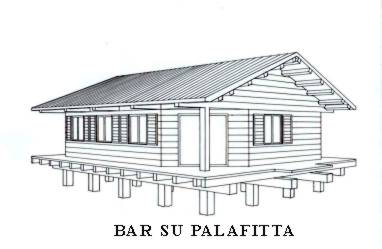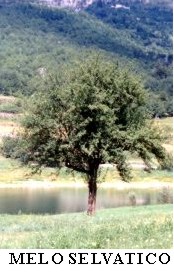COMUNITA'
MONTANA ALTO ASTICO E POSINA con sede in ARSIERO - VICENZA -
PROGETTO
PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI LAGHETTI DI LAGHI E ARSIERO
(VI)

ELENCO DELLE TAVOLE
REALIZZATE
Analisi delle trasformazioni:
1) Le acque: catasto napoleonico - Laghi;
2) Le acque: catasto napoleonico - Castana;
3) Le acque: catasto austriaco - Laghi;
4) Le acque: catasto austriaco - Castana;
5) Le acque: catasto attuale;
6) Le acque: variazioni del regime idrico;
7) Le colture: catasto austriaco;
8) Le colture: catasto attuale;
9) I fabbricati: catasto napoleonico;
10) I fabbricati: catasto austriaco;
11) I fabbricati: catasto attuale;
12) I fabbricati: variazioni dell'assetto urbanistico.
La situazione attuale:
13) Assetto geologico;
14) Uso del terreno;
15) Le previsioni dei piani regolatori generali;
16) Gli interventi attuati nel passato;
17/a) La vegetazione e le attrezzature;
17/b) La vegetazione e le attrezzature;
17/c) La vegetazione e le attrezzature;
17/d) La vegetazione e le attrezzature;
18) Assonometria monometrica.
Il progetto :
19/a) La vegetazione e le attrezzature;
19/b) La vegetazione e le attrezzature;
19/c) La vegetazione e le attrezzature;
19/d) La vegetazione e le attrezzature;
20) Assonometria monometrica;
21) Quadro generale degli interventi previsti
22/a) Elaborazioni prospettiche computerizzate;
22/b) Elaborazioni prospettiche computerizzate;
22/c) Elaborazioni prospettiche computerizzate;
22/d) Elaborazioni prospettiche computerizzate;
22/e) Elaborazioni prospettiche computerizzate:
23/a) Sezione modello tridimensionale;
23/b) Sezione modello tridimensionale
23/c) Sezione modello tridimensionale
Le tavole si
possono consultare c/o gli uffici della Comunità Montana, Arsiero
via Europa, tel 0445 740 529.
RELAZIONE
TECNICO-ILLUSTRATIVA
INTRODUZIONE
L'economia locale è stata sempre basata su un'agricoltura povera,
sulla vendita di legname da ardere e su un piccolo artigianato. La carenza
di buone vie di penetrazione ha sempre impedito la nascita e lo sviluppo
di attività artigianali di un certo respiro. Se da un lato ciò
ha causato l'esodo della popolazione, dall'altro ha favorito la conservazione
di un ambiente sorprendente per scorci paesaggistici, per ricchezza
di verde e tranquillità. Inoltre la valle è caratterizzata
da un buon clima e da un buon soleggiamento.
Con l'evoluzione culturale in atto nella società, la vallata
ha certamente tutte le credenziali per diventare la meta di un turismo
qualificato e rispettoso dei beni ambientali.
Il paese di Laghi è collegato con una strada provinciale di discreta
percorribilità (andrebbe comunque migliorata in alcuni punti)
direttamente ad Arsiero da cui dista 8 km. E' raggiungibile in mezz'ora
da Schio e Thiene e in un'ora da Vicenza e da Bassano: il casello dell'autostrada
Valdastico dista 20 km.
Queste limitate percorrenze rendono la zona adatta anche per il turismo
domenicale, vista l'ampia area cui può far riferimento.
IL PIANO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE
Recupero
Le finalità
di un piano di recupero ambientale non sono così agevoli da precisare
come potrebbe sembrare a prima vista: non si tratta infatti di un semplice
recupero naturalistico, di una mera operazione di ripristino di un ipotetico
"stato di natura", ma di un'operazione ben più complessa,
che coinvolge non solo gli aspetti naturali ma anche quelli culturali
e il rapporto dell'uomo con l'ambiente.
L'ambiente "naturale" così come noi lo conosciamo e
viviamo è infatti il risultato di una fortissima azione antropizzatrice:
gli insediamenti umani, le strade e i sentieri, la ceduazione, il disboscamento
e la creazione di pascoli, l'introduzione di nuove specie arboree, i
terrazzamenti dei prati, l'imbrigliamento dei torrenti e la costruzione
di ponti hanno profondamente modificato anche l'ambiente montano.
Questi interventi hanno dato luogo ad una serie di paesaggi ben caratterizzati
(tav. 14) che possiamo, nel nostro caso, così classificare:
- boschi: pecceto, faggeto, castagneto, ostrieto;
- pascolo con frutteto;
- ambienti umidi;
- insediamenti umani (case ed orti).
Si tratta di interventi e di paesaggi che esprimono un rapporto tra
l'uomo e l'ambiente ben definito e stabilizzato da secoli (tavv. 7/12,
relative alle colture e ai fabbricati), caratterizzati da un raggiunto
equilibrio tra l'uomo e le risorse naturali. Gli interventi recenti
di imbrigliamento e di regimazione delle acque hanno invece dato esiti,
dal punto di vista ambientale, non del tutto soddisfacenti (tavv. 1/6
, tav. 16).
Nell'ambito botanico si definisce vegetazione climax il tipo di vegetazione
rappresentante la fase definitiva, stabile, in relazione al clima regionale,
la cui possibile evoluzione sarebbe solo in senso regressivo: allo stesso
modo potremmo allora definire paesaggio climax l'insieme degli elementi
che caratterizzano ciascuno dei paesaggi precedentemente classificati.
Primo obiettivo del presente lavoro è stato perciò quello
di definire le caratteristiche di ognuno di questi paesaggi, in modo
da:
- ricavarne i processi formativi;
- individuare le situazioni di degrado o di errato intervento sull'ambiente
(tav. 16);
- definire le norme per la manutenzione, l'intervento e il ripristino.
Valorizzazione
La contemporanea
esigenza di valorizzare turisticamente la zona, per contrastarne il
declino economico, pone il problema della costruzione di nuove attività,
infrastrutture e manufatti. Per un corretto ed armonico inserimento
nell'ambiente si è ritenuto di procedere secondo due direttive:
a - localizzazione degli interventi in aree "deboli", degradate
o prive di una caratterizzazione specifica: in questo modo l'intervento
costruttivo realizza contemporaneamente il recupero ambientale, senza
toccare le aree circostanti;
b - estensione a questi interventi, per quanto possibile, della filosofia
costruttiva tradizionale, basata sul ricorso a tipologie rigorose, tecniche
costruttive semplici e sull'uso di materiali locali come la pietra e
il legno: si evita così il doppio pericolo da un lato di realizzare
manufatti estranei all'ambiente circostante, dall'altra di cadere nel
pittoresco o di adottare tipologie solo apparentemente congrue (come
quelle dei parchi urbani) ma che in realtà snaturerebbero l'ambiente.
ANALISI DELLE TRASFORMAZIONI
Le acque
(tavv. 1/6)
Il regime idrico,
fatte salve le inevitabili discrepanze grafiche, risulta molto variato
nel tempo, in ragione anche del regime torrentizio dei corsi d'acqua.
L'esigenza di imbrigliare i torrenti al fine di evitare dissesti idrogeologici
e il desiderio di stabilizzare il regime idrico dei laghetti nel corso
dell'anno hanno portato ad una serie di interventi che hanno modificato
profondamente l'assetto ambientale della zona (tav. 16).
Le colture
(tavv. 7/8)
Il confronto fra
il catasto attuale e quello austriaco evidenzia modeste variazioni sostanziali:
risulta solo in alcune zone un certo recupero di terreno agricolo a
scapito delle zone boscate. Tenuto conto che la situazione rappresentata
nel catasto attuale è riferibile agli anni '60 e che successivamente
si è assistito ad un lento abbandono delle aree coltivate si
può concludere che la situazione attuale è sostanzialmente
uguale a quella del secolo scorso. Unica variazione degna di nota: il
recupero a pascolo della confluenza fra i due torrenti, in seguito al
loro imbrigliamento.
I fabbricati
(tavv.10/12)
Le tavole evidenziano
un incremento edilizio limitato: la zona dal punto di vista urbanistico
è rimasta praticamente inalterata.
LA SITUAZIONE ATTUALE
Assetto geologico
(vedi tav. 13)
Uso del terreno (tav.14)
Boschi (schede 17-20.1/18)
Consideriamo qui solo l'ostrieto, tipico della zona.
Nelle aree calcaree che vanno dai prati del fondovalle fino alle quote
di 660-700 m compare un bosco misto definito "ostrieto" (od
"orno-ostrieto") per la presenza prevalente del carpino nero
(Ostrya carpinifolia) e dell'orniello (Fraxinus ornus). Altre essenze
tipiche sono: carpino bianco (Carpinus betulus), nocciolo (Corylus avellana),
corniolo (Cornus mas), acero campestre (Acer campestre), farinaccio
(Sorbus aria), tiglio selvatico (Tilia cordata), sorbo degli uccellatori
(Sorbus aucuparia) specie nei pressi delle contrade, viburno (Viburnum
lantana), e altre specie arbustive: pruno selvatico (Prunus spinosa),
rosa canina, edera (Hedera helix), la vitalba (il veneto "visone")
(Clematis vitalba). Nei versanti più aridi troviamo il ginepro
(Juniperus communis), il pero corvino (Amelanchier ovalis), il biancospino
(Crataegus monogyna e Crataegus oxicantha), il ligustro (Ligustrum vulgare).
Radi pecci (Picea excelsa) sono scesi dalle quote superiori.
E' un bosco di origine antropica, almeno in buona parte: sembra infatti
derivare dalla modificazione di un originario querceto; la maggiore
capacità rigenerativa del carpino nero e dell'orniello, la loro
maggior resistenza alla ceduazione (la normale forma di governo di questo
bosco), le loro spiccate capacità pioniere avrebbero portato
all'eliminazione quasi totale delle querce e delle altre essenze. Sempre
le capacità pioniere del carpino nero e dell'orniello permettono
il naturale e spontaneo imboschimento dei prati aridi e abbandonati.
Essendo scarso o assente il peccio, questo tipo di bosco fornì
raramente legname da costruzione o da opera, ma soprattutto legna da
ardere e da carbone.
Pascolo con frutteto (schede 17-20.1/18)
Attorno alle contrade e nei fondovalle i boschi lasciano frequentemente
il posto ai pascoli. I seminativi, poco redditizi, sono quasi scomparsi:
la forma di coltura più diffusa è perciò rappresentata
dal prato stabile, sfalciato e concimato. E' una cenosi mantenuta esclusivamente
dalle pratiche colturali dell'uomo: l'abbandono ne comporta infatti
la sostituzione da parte del bosco. Le erbe che la caratterizzano sono:
l'avena altissima (Arrhenatherum elatius), l'erba mazzolina (Dactylis
glomerata), il ranuncolo (Ranunculus acris), la margherita (Leuchanthemum
vulgare), il ginestrino (Lotus corniculatus).
I pascoli raggiungono anche i pendii più ripidi, mediante il
terrazzamento con muretti a secco, elemento caratteristico della vallata.
Isolati alberi da frutto punteggiano i pascoli.
Ambienti umidi (schede 17-20.1/18)
La pozza d'alpeggio, quando è indisturbata, presenta una zonazione
tipica. Procedendo dall'esterno all'interno abbiamo:
a - specie igrofile, in grado però di sopportare periodi di siccità,
come il migliarino (Deschampsia caespitosa), alcuni carici (genere Carix),
il giunco tenace (Juncus inflexus);
b - specie elofite, legate cioè ad un tenore idrico del suolo
costante ed elevato: mestolaccia (Alisma plantago-aquatica), coltellaccio
(Sparganium erectum), tifa (Typha latifolia), cannuccia (Phragmites
australis), gramigna acquatica (Glyceria plicata);
c - specie idrofite, cioè piante che vivono immerse o galleggianti
sull'acqua: erba tinca (Potamogeton natans), callitriche (Callitriche
stagnalis detta anche C. palustris), lenticchia d'acqua (Lemna minor).
Si tratta di una zonazione poco più che ipotetica, dato il disturbo
causato dal bestiame col calpestio, il pascolamento, le deiezioni, e
dalle operazioni di pulizia praticate periodicamente allo scopo di evitare
l'interramento naturale.
Nel nostro caso l'intervento di impermeabilizzazione ha fortemente perturbato
il biotopo esistente.
Insediamenti umani
La casa della montagna vicentina è posta a cavallo, come tipologia,
fra le costruzioni di pietra della Lessinia e quelle prevalentemente
lignee del Cadore. Per la presenza di calcari a sfaldatura naturale
e di graniti ottenibili in blocchi compatti e anche a lastami, scarso
è l'uso del legno: la cortina muraria è completata anche
a sud da una chiusura realizzata in pietra, contrariamente all'uso di
altre zone del Veneto, che tamponano la facciata meridionale con materiale
reticolare ligneo. Soltanto i fienili con sottostante stalla, spesso
accostati e non sovrapposti o sottostanti l'abitazione, sono aperti
verso sud e completati da chiusure in legno (popolazione cimbra).
La prevalenza della pietra sul legno può forse essere attribuita
a ragioni storiche, forse ad una maggior disponibilità del primo
materiale rispetto al secondo (ricordiamo che gli ostrieti fornivano
poco legname da costruzione).
Le abitazioni tendono ad unirsi in aggregati lineari disposti lungo
le curve di livello.
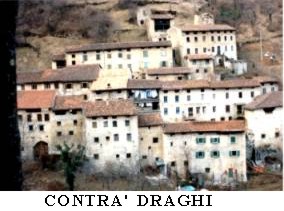
Le previsioni del Piano Regolatore Generale
(vedi tav. 15)
Gli
interventi attuati nel passato
(tav. 16)
Ponte sul torrente Zara (a monte)
Si tratta di una struttura in cemento armato con parapetto metallico
in contrasto con l'ambiente circostante. Il parapetto risulta visibilmente
deformato da numerosi urti di automezzi; l'uso del ferro crea la necessità
di una continua manutenzione.
Sistemazione della confluenza dei torrenti Zara e Scarabozza
La confluenza dei due torrenti è sempre stata un punto critico
dando luogo a numerosi straripamenti e variazioni degli invasi (tavv.
1/6). Si sono perciò rese necessarie consistenti opere di regimazione
delle acque; tali opere, pur essendo idonee dal punto di vista idraulico,
non risultano adeguate sotto il profilo ambientale. L'intervento, concentrandosi
solo sulle acque, ha trascurato il recupero dei terreni, lasciando incolta
e inutilizzabile un'ampia area tra i due torrenti. L'impatto visivo
della briglia con rastrello in ferro posta a valle risulta inoltre eccessivo.
Ponte sul torrente Zara (intermedio)
Il ponte risulta inadeguato alle esigenze del traffico e imbruttito
dai parapetti in calcestruzzo.
Intubamento ed
immissione nel lago del torrente Zara
Allo scopo di convogliare senza perdite le acque fino ai laghetti, il
corso del torrente è stato intubato a monte e la foce è
stata cementificata. Mentre i tubi di cemento sono abbastanza ben mascherati,
risulta invece inaccettabile esteticamente la soluzione realizzata per
l'immissione del torrente nel lago maggiore.
Strada di collegamento
con Ca' Zanzana
Il sistema di percorsi recentemente realizzato permette di collegare
agevolmente l'abitato con l'area di ristoro prevista sul lato nord del
lago maggiore (vedi tavv. 17/a/b). L'intervento è stato studiato
ponendo particolare attenzione all'inserimento ambientale.
Impermeabilizzazione
del fondo dei laghi con bentonite
Allo scopo di stabilizzare il regime idrico dei laghetti, evitandone
il prosciugamento nei periodi di secca, gli invasi sono stati impermeabilizzati
con fanghi bentonitici. Tuttavia il livello delle acque varia ancora
di alcuni metri dando luogo ad una fascia melmosa, scivolosa e priva
di vegetazione lungo le rive.
Sistemazione
di un sentiero attorno al lago minore
Un percorso attorno al laghetto minore è già stato realizzato;
le rive presentano invece lo stesso problema del lago maggiore.
Muro di contenimento
della strada provinciale
L'allargamento della strada provinciale ha comportato la realizzazione
di un poderoso muro di contenimento, prospiciente il laghetto minore,
dal forte impatto visivo.
Sistemazione
dell'emissario
L'emissario è stato completamente cementificato acquistando un
aspetto totalmente artificiale.
Ponte sul torrente
Zara (a valle)
Si tratta di una struttura in cemento armato con parapetto metallico
richiedente una continua manutenzione.
La vegetazione
e le attrezzature ( tavv. 17/a/b/c/d-18)
Si rileva:
a - la presenza di essenze arboree in contrasto con l'ambiente (in quanto
non caratteristiche dei paesaggi precedentemente individuati);
b - la carenza di strutture turistico ricettive.
IL PROGETTO
La vegetazione e le attrezzature ( tavv. 19/a/b/c/d-20 e schede
17-20.1-18)
Quadro generale degli interventi previsti (tav. 21)
Ponte sul torrente Zara (a monte)
Si propone la ricostruzione del ponte secondo una tipologia ad arco
utilizzando la pietra locale. Il nuovo ponte dovrà essere dimensionato
tenendo conto dell'impianto sportivo adiacente in corso di realizzazione
e del previsto campeggio.
Sistemazione
della confluenza dei torrenti Zara e Scarabozza
Le potenzialità turistiche della zona, consigliando la realizzazione
di un piccolo campeggio, permettono di recuperare quest'area abbandonata.
Il sito risulta infatti ideale per i seguenti motivi:
a - è adiacente alla strada provinciale;
b - ha un limitato impatto visivo data la posizione relativamente ribassata;
c - non interferisce paesaggisticamente con i laghetti;
d - rappresenta un'opportunità per il recupero di un'area degradata
e improduttiva.
Ponte sul torrente
Zara (intermedio)
Si propone l'allargamento del ponte con struttura e parapetti in pietra
locale.
Intubamento ed immissione nel lago del torrente Zara
La necessità di realizzare un ponticello pedonale per completare
il percorso attorno ai laghetti rappresenta l'occasione per ripensare
la sistemazione dell'area circostante. Il ponte sarà costituito
da un arco in pietra; dei massi posti sul letto della foce ne maschereranno
il fondo in cemento (che andrà ribassato).
Strada di collegamento con Ca' Zanzana
Le preesistenze e i collegamenti agevoli hanno consigliato di concentrare
su questa sponda gran parte delle attrezzature salvaguardando l'integrità
naturalistica delle altre aree. Accanto all'edifico esistente di cui
è prevista la trasformazione in locanda, si prevedono pertanto
la realizzazione di un'area per pic-nic, di un pontile in legno e di
un piccolo bar su palafitte; sulla riva adiacente, al di là della
foce, si realizzerà un percorso fitness.
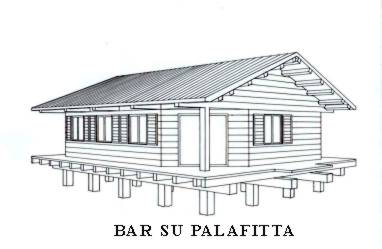
Impermeabilizzazione
del fondo del lago con bentonite
Si prevede di mettere a dimora un canneto tra il lago e il percorso
da creare attorno alle sue rive, rendendo il paesaggio più naturale
e impedendo agli escursionisti di raggiungere la fascia d i fango pericolosa;
alcuni pontili permetteranno invece un contatto diretto con le acque.
Sistemazione
di un sentiero attorno al lago minore
Si prevede anche in questo caso la messa a dimora di un canneto.
Muro di contenimento
della strada provinciale
Si prevede la mascheratura del muro con una cortina di alberi.
Sistemazione
dell'emissario
Si propone di rivestire i muri di contenimento con pietra locale e vegetazione,
e di nascondere il fondo con dei massi.
Ponte sul torrente
Zara (a valle)
Date le dimensioni ragguardevoli, non è proponibile la ricostruzione
del ponte secondo tipologie tradizionali. Si prevede quindi la sostituzione
del solo parapetto realizzandone uno in legno.
Architetto Nicola
Busin
ESSENZE ARBOREE: SCHEDE ILLUSTRATIVE
17/20.1 ABETE ROSSO
Picea excelsa (Picea abies)
famiglia: Pinacee
altezza: supera i 50 m
forma: piramidale
corteccia: sottile e squamosa, distaccantesi in placche regolari; colore
brunastro con sfumature rosseggianti
foglie: sempreverdi; aghiformi, lucide, con apici appuntiti e un po'
pungenti; solitarie sui rami
coni: maschili: spesso raggruppati per 2-6, color rosso o verde che
muta in giallo a maturità; femminili eretti, isolati, rosseggianti,
posti sulla parte apicale dei rami
pigne: pendule
fioritura: aprile-maggio
longevità: fino a 400-500 anni
habitat: è il principale componente della foresta subalpina di
aghifoglie (1000-2000 m)
17/20.2 ACERO (A. CAMPESTRE, OPPIO)
Acer campestre
famiglia: Aceracee
altezza: fino a 15-20 m
forma: tondeggiante, con chioma leggera; spesso arbustivo
corteccia: bruno giallastra, con sfumature rosse, divisa in placche
verticali
foglie: lungamente picciolate, con lamina palmata e margine lobato (3-5
lobi)
infiorescenze: corimbi eretti di piccoli fiori verde giallastri
frutti: samare ad ali opposte
fioritura: aprile-maggio
habitat: boschi mesofili di latifoglie (0-1600 m); ampiamente diffuso
dall'uomo
17/20.3 CANNUCCIA DI PALUDE
Phragmites australis
famiglia: Graminacee
altezza: 1,5-3
forma: pianta alta, con fusti robusti e non ramificati
foglie: larghe e coriacee, lisce, di color grigio-verde,le cui guaine
circondano il fusto e si sovrappongono
infiorescenze: grandi infiorescenze erette che possono diventare pendule
quando i frutti maturano; ogni fiore ha una fitta frangia di peli bianchi
e setosi
habitat: margini dei fiumi, laghi e acque salmastre
17/20.4 CARPINO (C. BIANCO)
Carpinus betulus
famiglia: Corilacee
altezza: fino a 20 m
forma: piramidale-tondeggiante, con chioma densa
corteccia: liscia, grigio cenere, screpolata longitudinalmente
foglie: caduche; semplici, alterne, verde cupo superiormente e più
chiare inferiormente; apice acuto, base rotonda o cuoriforme
infiorescenze: amenti penduli a sessi separati
fioritura: aprile-maggio
habitat: boschi cedui e fustaie (querco-carpineti); 0-1000 m
17/20.5 CARPINO NERO (CARPINELLO)
Ostrya carpinifolia
famiglia: Corilacee
altezza: fino a 15 m
forma: slanciata e leggera
corteccia: marrone-grigio, a lungo liscia; negli esemplari maggiori
è percorsa da screpolature fitte e poco profonde
foglie: caduche; ovato-acuminate; margine seghettato
infiorescenze: in amenti; le maschili strette e lunghe; le femminili
si evolvono in una infruttescenza vistosa di colore bianco-sericeo
fioritura: aprile-maggio
habitat: rilievi, dalle colline fino a 1000-1400 m, in cespuglieti e
cedui
17/20.6 CILIEGIO
Prunus avium
famiglia: Rosacee
altezza: fino a 20 m
forma: approssimativamente piramidale; rami con andamento ascendentecorteccia:
rosso-brunastra o rosso grigiastra; con l'età tende ad assumere
un caratteristico aspetto anulato
foglie: caduche; alterne, a lembo oblanceolato od obovato
infiorescenze: in corimbi ombrelliformi di pochi fiori a petali bianchi
obovati
fioritura: aprile maggio
frutto: drupa globosa di colore variabile tra il rosso e il nero porporino
(la ciliegia), edule
habitat: foreste di latifoglie fino a circa 1500 m
17/20.7 CORNIOLO
Cornus mas

famiglia: Cornacee
altezza: fino a 8 m
forma: piccolo albero o arbusto
corteccia: grigiastra
foglie: caduche; opposte, da ovali ad ellittiche, con 3-5 paia di nervature
vistose e margini non dentati
infiorescenze: di 1 cm di diametro, con 10-25
fiori, brevemente peduncolate e con 4 brattee giallastre alla base
fioritura: febbraio-marzo
frutto: ovoidale, lungo 1,5 cm, pendulo, carnoso, che diventa di color
rosso vivo a maturità, edule
habitat: rive, boscaglie, margini dei boschi, generalmente su terreni
calcarei
17/20.8 LARICE (L. EUROPEO, L. COMUNE)
Larix decidua
famiglia: Pinacee
altezza: fino a 40 (50) m
forma: piramidale
corteccia: grigio-bruno, screpolantesi con l'età in grosse placche
foglie: caduche; aghiformi, verde chiaro, appuntite ma non pungenti;
a ciuffi di 30-40; giallo dorate in autunno
coni: maschili: giallo dorati; femminili rosso carminio, spesso accompagnati
dalle pignette dell'anno precedente
pigne: erette, ovoidi
fioritura: aprile-maggio
longevità: isolato può diventare secolare
habitat: soprattutto in clima continentale, fino al limite degli alberi
(0-2400 m)
17/20.9 MELO
Malus domestica (Malus communis)
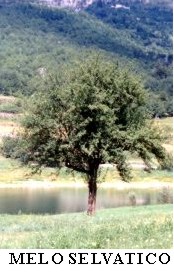
famiglia: Rosacee
altezza: fino a 15 m
forma: alberello
corteccia: grigia e screpolata lungo il tronco
foglie: caduche; larghe, dentate, leggermente lanose sulla pagina superiore,densamente
lanose sotto
infiorescenze: corimbi vistosi
frutti: pomi (eduli), da verdi a rossi e gialli, dolci o aspri, eduli
fioritura: aprile-maggio
habitat: la varietà "sylvestris"è tipica componente
della foresta planiziale padana nei suoi aspetti meno umidi. Le varietà
coltivate sono oltre 1000, coltivate e naturalizzate qua e là
17/20.10 NOCE
Juglans regia
famiglia: Juglandacee
altezza: fino a 15 m
forma: rotondeggiante; tronco robusto e diritto
corteccia: grigio chiaro, screpolata verticalmente con l'età
foglie: caduche; composte imparipennate, con segmenti di dimensioni
crescenti verso l'apice
infiorescenze: maschili: ad andamento pendulo; femminili: in amenti
pauciflori terminali
frutto: verde ovale sferico, con seme edule (noce), edule
fioritura: aprile-maggio
habitat: coltivato o naturalizzato qua e là sotto i 1200 m
17/20.11 NOCCIOLO
Corylus avellana
famiglia: Corilacee
altezza: fino a 7-8 m
forma: arbustiva, con fusto densamente ramificato fin dalla base
corteccia: bruno ramato, lucida, con lenticelle evidenti nei rami giovani
foglie: caduche; semplici, alterne, con picciolo breve; lamina ellittica
o tondeggiante con base cuoriforme
infiorescenze: maschili: in amenti penduli allungati, gialli a maturità;
fiori femminili solitari, simili a gemme
frutto: nocciola (edule)
fioritura: marzo-aprile; precede l'emissione delle foglie
habitat: nel sottobosco di foreste di latifoglie e aghifoglie; colonizzatore,
si trova anche in altri svariati ambienti (0-1700 m); coltivato per
il frutto
17/20.12 ORNIELLO (ORNIO, FRASSINO DA MANNA)
Fraxinus ornus
famiglia: Oleacee
altezza: fino a 20 m
forma: rotondeggiante
corteccia: grigia molto liscia
foglie: con 5-9 foglioline da ovate a lanceolate, chiaramente picciolettate,irregolarmente
e finemente dentate
infiorescenze: con 4 petali nastriformi, lunghi 5-6 mm
frutto:di 2-2.5 cm, appuntito o inciso all'apice
fioritura: aprile-maggio
habitat: boschi misti, boscaglie e luoghi rocciosi della regione mediterranea
e dell'Europa centro-meridionale
17/20.13 PADO (CILIEGIO A GRAPPOLI)
Prunus padus
famiglia: Rosacee
altezza: fino a 15 m
forma: più spesso arbustiva; quando è arborea, ha chioma
espansa e rami anche molto bassi sul tronco
corteccia: scura, con abbondanti lenticelle, si fessura con l'età
e tende a sfaldarsi
foglie: caduche; alterne, sottili, picciolate, con lamina ovato-oblunga,
acuta all'apice e troncata alla base
infiorescenze: racemi penduli di fiori bianchi e profumati
frutti: drupe in forma di piccole ciliege
fioritura: maggio-giugno
habitat: boschi ripariali nelle regioni settentrionali (0-1900 m)
17/20.14 PIOPPO TREMOLO (TREMOLO)
Populus tremula
famiglia: Salicacee
altezza: fino a 20 m
forma: fusto diritto e slanciato, con numerosi rami addensantisi verso
l'alto
corteccia: bianco-grigiastra o giallognola, a lungo liscia
foglie: caduche; da quasi tonde ad ovali, a margine ondulato. Piccioli
appiattiti lateralmente, il che consente il tremolio alle lamine fogliari.
Foglie dei polloni triangolari-cuoriformi e grigio-pelose; foglie superiori
che ben presto diventano glabre.
infiorescenze: amenti unisessuali, lunghi fino a 12 cm
fioritura: marzo-maggio
habitat: radure soleggiate e umide di varie formazioni forestali, specie
del piano montano (0-2000 m)
17/20.15 PRUGNOLO (PRUNO SELVATICO, SPINO NERO, STROZZAPRETI)
Prunus spinosa
famiglia: Rosacee
altezza: fino a 4 m
forma: arbusto, forma molti polloni, dando così origine a macchie
corteccia: i giovani rami sono generalmente pelosi
foglie: caduche; piccole, finemente dentate, color verde smorto, glabre
sulla pagina superiore
infiorescenze: fiori di 1-1,5 cm, per lo più solitari, su brevi
peduncoli glabri di circa 5 mm, ma in folti gruppi sui germogli
frutti: ricoperti di pruina, nerobluastri, di 1,5-2 cm, molto astringenti,
eduli
habitat: luoghi aridi, pendìi, macchie, boschi, siepi e lungo
le vie
17/20.16 SALICE BIANCO
Salix alba
famiglia: Salicacee
altezza: fino a 30 m
forma: arrotondata, con fusto spesso biforcato già nella parte
bassa; molto diffusa anche la forma arbustiva
corteccia: grigio scuro e liscia; si screpola longitudinalmente con
gli anni
foglie: caduche; lanceolato-lineari, finemente dentate, appuntite,con
riflessi argentati nella pagina inferiore; sono coperte di peli argentei,
come i rami e le gemme
infiorescenze: amenti: i mascili densiflori, i femminili più
lassi
fioritura: febbraio-aprile
habitat: prevalentemenete lungo i grandi fiumi (0-1200 m)
17/20.16 SALICI PIANGENTI
Salix babylonica
famiglia: Salicacee
altezza: fino a 10 m
forma: caratteristica chioma pendula
corteccia: bruna
foglie: lanceolato-lineari, lungamente acuminate
all'apice, portate da un picciolo lungo 3-5 cm
infiorescenze: erette unisessuali portate da individui diversi
fioritura: aprile-maggio
habitat: prevalentemente lungo i fiumi
ibridi: la maggior parte dei salici piangenti
impiegati attualmente nel giardinaggio sono frutto di ibridazione tra
"S. babylonica" e altri salici
17/20.17 SAMBUCO
Sambucus nigra
famiglia: Caprifoliacee
altezza: fino a 10 m
forma: arbusto grande e molto ramoso o talora piccolo albero
corteccia: grigia, liscia, con lenticelle
foglie: caduche; pennato-composte
infiorescenze: appiattite superiormente, fiori fortemente odorosi color
bianco crema
frutti: in infruttescenze spesso pendule, carnosi, di 6-8 mm, generalmente
neri, ma talora verdi
fioritura: giugno-luglio
habitat: boschi umidi, siepi, luoghi incolti di tutta l'Europa, spesso
coltivato al Sud
17/20.18 SANGUINELLO
Cornus sanguinea
famiglia: Cornacee
altezza: fino a 4 m
forma: arbusto, produce molti polloni
corteccia: rosso scuro
foglie: caduche; opposte, intere, di 4-10 cm, con vistose nervature
laterali
ricurve, di color verde pallido, che in autunno diventano rosso-porpora
scuro
infiorescenze: numerose, in ombrelle di 4-5 cm di diametro, portate
all'estremità dei rami; quattro petali, stretti, molto patenti
frutti:neri lucidi, amari, in dense infruttescenze
habitat:colonizza prati e pascoli abbandonati, specialmente su terreni
alcalini e neutri
GLOSSARIO
achenio: frutto secco che non si apre a metà per lasciare uscire
i semi.
amento: densa spiga, di solito pendula, di piccoli
fiori per lo più unisessuati.
aghifoglia: pianta arborea con foglie aghiformi.
biotopo: luogo caratterizzato da condizioni ambientali
unitarie e peculiari.
bràttea: piccola struttura fogliacea o
squamosa, alla cui ascella è spesso inserito un fiore.
caducifoglia: pianta a foglie che cadono in autunno
(cioè a foglie decidue).
ceduo: tipo di bosco che viene tagliato periodicamente,
lasciando poi che le ceppaie germoglino.
cenosi: comunità; insieme di popolazioni
di specie diverse che vivono in un determinato biotopo.
colonizzatrice: pianta che tende ad occupare
suoli liberi da copertura vegetale, iniziando una serie evolutiva spontanea
di vegetazione che si concluderà (in assenza di perturbazioni
antropiche) dopo un tempo assai variabile, con l'avvento della vegetazione
climax.
cono: caratteristico organo, rotondeggiante o
allungato, costituito da un asse che porta molte squame sovrapposte
ai margini (embriciate), che a maturità portano il polline oppure
gli ovuli e poi i semi. detto anche strobilo o, impropriamente, pina
o pigna.
corimbo: infiorescenza in cui i singoli fiori
sono portati da peduncoli inseriti sull'asse principale a diverse altezze,
ma arrivano tutti alla stessa altezza o quasi; l'infiorescenza ha quindi
la superficie superiore piana o più o meno convessa.
deciduo: che cade. Le piante caducifoglie, che
perdono le foglie in autunno, hanno le foglie decidue.
drupa: frutto carnoso, dotato di nòcciolo
racchiudente l'unico seme.
edule: mangereccio.
fustaia: bosco in modo tale che gli alberi risultano
nati da seme; il turno di taglio è in generale piuttosto lungo.
imparipennata: foglia pennata composta da un
numero pari di foglioline.
lanceolato: a forma di lancia; dotato di punta,
con la massima larghezza sotto la metà, e regolarmente restringentesi
verso la base
latifoglia: pianta arborea a foglie con lamina
espansa, caducifoglia o sempreverde.
lenticella: "poro respiratorio" della
corteccia, sugheroso; si può trovare, oltre che sui rami, su
alcuni frutti.
mesofila: pianta che manifesta esigenze medie
per quanto riguarda i diversi fattori ecologici.
oblanceolato: da ob (capovolto); perciò
con la parte più larga vicino all'apice e non, come di solito,
alla base.
obovato: vedi oblanceolato.
patente: si dice di organo che diverge considerevolmente
da quello su cui è inserito, dirigendosi verso l'esterno; così
"rami patenti", ossia rivoti in fuori; "peli patenti",
non appressati alla superficie dell'organo che li porta; ecc.
planiziale: aggettivo riferito a piano, pianura.
pennata: si dice di una foglia composta le cui
foglioline sono inserite regolarmente da ambo le parti del prolungamento
del picciòlo o rachide.
pioniera: pianta che si insedia, per prima o
fra le prime, in suoli non ricoperti da vegetazione.
pollone: germoglio che spesso ha origine sotto
terra, apparendo sopra il suolo talora ad una certa distanza dal fusto
principale.
pruìna: formazione, per lo più
di natura cerosa, che può rivestire diverse parti della pianta
(per esempio frutti o foglie), dando loro una colorazione più
o meno azzurrina.
rachide: prolungamento del picciòlo, portante
le foglioline; asse di un cono o di una infiorescenza ad amento o spiga.
ripariale: vivente sulle rive (di un fiume o
di un lago).
sàmara: achenio alato.
sempreverde: che rimane verde tutto l'anno; si
dice di piante a foglie persistenti, in contrapposto a quelle a foglie
caduche (caducifoglie), che le perdono al giungere della cattiva stagione.
sessile: sprovvisto di gambo.
spiga: infiorescenza composta da tanti fiori
sessili inseriti su un asse.
I dati sugli ambienti e sugli alberi e il glossario
sono stati tratti da:
AA. VV. (curatore: arch. Ettore Vio). La casa
rurale nel Veneto, Spinea (VE), Multigraf, 1983.
Brosse, Jacques. Storie e leggende degli alberi, Pordenone, Studio Tesi,
1989.
Carollo, Liverio. Guida escursionistica delle Valli di Posina, di Laghi
e dell'Altopiano di Tonezza (Prealpi Vicentine), Seghe di Velo, Club
Alpino Italiano, Sez. di Thiene, 1983.
Curti, Luigino e Scortegagna, Silvio. Erbario Vicentino, Padova, Banca
Popolare Vicentina, 1992.
Devoto,Giacomo e Oli,Gian Carlo.Dizionario della lingua italiana, Firenze,
Le Monnier, aprile 1982 (1^ ed. 1971).
Polunin, Oleg. Guida agli alberi e arbusti d'Europa, Bologna, Zanichelli,
1987 (1^ ed. italiana: 1977).
Sartori, Francesco. Gli alberi, Novara, Istituto Geografico de Agostini,
1986.
Il progettista capogruppo
dott. arch. Nicola Busin
COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA con sede
in ARSIERO - VICENZA -
PROGETTO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE
DEI LAGHETTI DI LAGHI E ARSIERO (VI)
PROGRAMMI E NORME TECNICHE RIFERITI ALLE VARIE FASI DI ATTUAZIONE DEL
PROGETTO.
Gruppo di progettazione :
Dott. Arch. NICOLA BUSIN progettista capogruppo;
Dott. Arch. SEBASTIANO ZANETELLO progettista ;
Dott.ssa PAOLA KLANTSCHNIK consulente botanico;
Dott. BERNARDINO ZAVAGNIN consulente geologico;
Geom. FRANCO COLMAN topografo.
Studio Architetto Nicola Busin, piazza F. Rossi
35 - 36011 Arsiero -Vi- tel/fax 0445/740369
NORME TECNICHE
- Pavimentazioni dei percorsi:
dovranno essere realizzate con l'uso "terra stabilizzata"
composta per ogni 100
kg da 20 kg di pietrischetto pezzatura 12-15 mm, 50 kg di sabbia, 15
kg di limo e 15 kg di
cemento portland 325.
- Pavimentazioni aree attrezzate :
è prevista l'utilizzazione di formelle o mattonelle in calcestruzzo
vibrato .
- Pavimentazioni parcheggi:
verranno utilizzate formelle in calcestruzzo forate in modo da fare
attecchire il manto erboso.
- Arredamento aree attrezzate:
è prevista l'utilizzazione di panche e tavoli in legno (*) .
- Percorso fitness:
verrà realizzato con attrezzi in legno (*) e pavimentazione in
formelle di cemento
- Costruzione muri di contenimento:
i muri di contenimento avranno il paramento esterno piatto in pietrame
locale calcareo (sasso
rotto) ; gli interstizi tra sasso e sasso dovranno essere ridotti al
minimo e lasciati liberi da malta.
- Costruzione e sistemazione ponti:
saranno realizzati con tipologia ad arco (tipica della zona) e rivestimento
esterno in pietrame
locale (come per i muri di contenimento). E' prevista la pavimentazione
della uperficie di
calpestio in lastre di pietra.
- Palafitte:
nella parte interrata nel fondo del lago saranno in calcestruzzo; nella
parte esterna saranno
costruite in pali di legno (*) impregnati con catrame per la porzione
entro l'acqua .
- Pontili:
verranno realizzati in legno (*) con un 1 bordo di 10 cm ai lati per
permettere il passaggio di
carrozzelle.
- Staccionate :
anche le staccionate saranno realizzate in legno (*) con forma e dimensione
simili a quelle già
recentemente realizzate (vedi progettazione esecutiva dello scrivente
studio).
- Bar su palafitte:
verrà costruito in legno (*) con tipologia tradizionale, tetto
a capanno con coppi laterizi.
(*) tutto il legno si intende trattato contro
la marcescenza e l'attacco di funghi ed
insetti.
Dicembre 1994.
Il progettista capogruppo
Arch. Nicola Busin
|